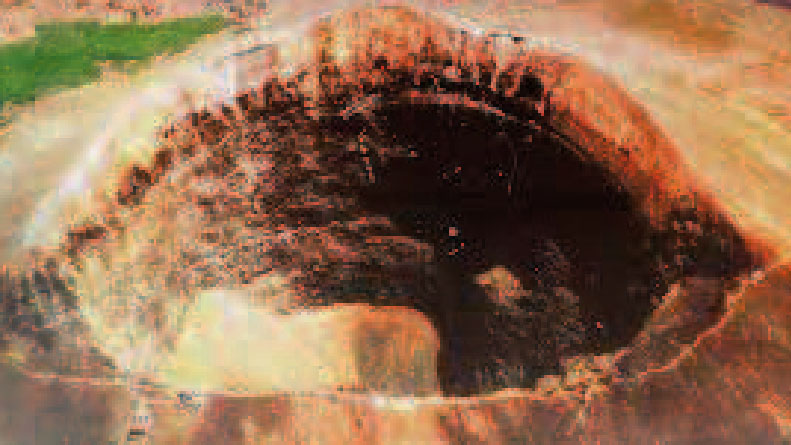La devastante eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., che distrusse Pompei e altre città circostanti come Ercolano, Boscotrecase, Oplonti e Stabiae, è stata a lungo oggetto di studio e analisi. Una recente ricerca, frutto di una collaborazione scientifica tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e il Parco Archeologico di Pompei, ha gettato nuova luce sugli effetti della sismicità durante quella catastrofica eruzione.
L’Indagine Multidisciplinare
Pubblicato sulla rivista “Frontiers in Earth Science”, lo studio intitolato “A novel view of the destruction of Pompeii during the 79 CE eruption of Vesuvius (Italy): syn-eruptive earthquakes as an additional cause of building collapse and deaths” ha coinvolto esperti in archeologia, vulcanologia, antropologia e archeosismologia. L’obiettivo era comprendere meglio gli effetti combinati dei fenomeni vulcanici e dei terremoti che accompagnarono l’eruzione.
Durante recenti scavi nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e riprofilazione delle scarpate nell’insula dei Casti Amanti, all’interno del Parco Archeologico di Pompei, sono stati rinvenuti i resti scheletrici di due individui. L’analisi di questi resti, insieme a evidenze di danni strutturali e crolli, ha permesso di ricostruire gli effetti devastanti dei terremoti che scossero Pompei durante l’eruzione.
Nuovi Elementi sull’Eruzione
Mauro Antonio Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv e co-autore dello studio, ha spiegato come la ricerca abbia aggiunto un tassello fondamentale alla comprensione degli eventi vissuti dagli abitanti di Pompei. Lo studio ha individuato il momento esatto dell’eruzione in cui la sismicità ha avuto effetti distruttivi, influenzando probabilmente le azioni dei Pompeiani durante la catastrofe.
L’eruzione iniziò nella tarda mattinata, ma fu solo intorno alle 13 che entrò nella sua fase parossistica. Una colonna eruttiva si innalzò dal vulcano, raggiungendo un’altezza di oltre 30 chilometri, e una pioggia di pomici iniziò a cadere su Pompei. Molti abitanti cercarono rifugio negli edifici, ma l’accumulo di pomici causò il cedimento di alcuni tetti, provocando le prime vittime.
Domenico Sparice, vulcanologo dell’Osservatorio Vesuviano e co-autore dello studio, ha raccontato come, dopo la pioggia di pomici, un breve declino dell’attività eruttiva spinse i sopravvissuti a credere che il peggio fosse passato. Tuttavia, forti terremoti continuarono a scuotere Pompei, preludio della seconda fase dell’eruzione. Plinio il Giovane, testimone oculare, descrisse questi terremoti nelle sue lettere, ricordando come essi annunciarono la formazione di una caldera a seguito del collasso di un ampio settore del vulcano.
Importanza degli Studi Multidisciplinari
Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei e co-autore dello studio, ha sottolineato l’importanza di un approccio multidisciplinare che vada oltre gli aspetti puramente vulcanologici. Questo tipo di ricerca permette di comprendere meglio la complessità degli eventi che portarono alla distruzione di Pompei e offre nuove prospettive sulla gestione del rischio vulcanico e sismico.